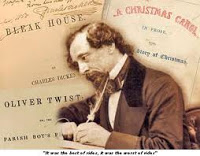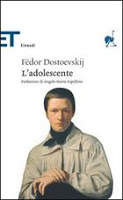L’adolescente, con la sua estrema ‒ persino dichiarata ‒ caoticità, non è probabilmente tra i romanzi più riusciti di Dostoevskij, almeno se lo consideriamo dal punto di vista della struttura narrativa, che appare infatti un po’ sghemba, piena di rimandi, anticipazioni, deviazioni, intrighi, colpi di scena, vicende ingarbugliate e personaggi contraddittori (Versilov è un personaggio emblematico sotto questo profilo: dongiovanni ma anche amante fedele, ateo ma nostalgico di Dio, nobile e ignobile a seconda dell’estro)… Insomma un caos nel quale Dostoevskij si destreggia con grandissima abilità, ma che a tratti sembra anche sfuggirgli un po’ di mano.
La storia è scritta sotto forma di “memorie”, redatte dal protagonista del romanzo, il ventenne Arkadij Makarovic Dolgorouki, figlio illegittimo del suddetto Versilov, proprietario terriero. Più in generale tutte le “memorie” del nostro adolescente, «potrebbero servire come materiale per una futura opera artistica […] nonostante il loro carattere caotico e casuale…», queste sono le parole che l’autore stesso ci consegna in filigrana nel finale, quasi scusandosi. Eppure nelle sue 554 pagine (Einaudi, traduzione di Eva Amendola Kühn), questo romanzo regala con grande generosità idee, spunti, acrobazie letterarie e analisi psicologiche degne della fama dello scrittore: se non è un capolavoro è comunque lo scritto di un genio.
Senza pretendere completezza ‒ non c’è pagina da cui non si potrebbe rilevare qualcosa di interessante ‒ volevo soffermarmi su alcuni passaggi e personaggi particolarmente significativi.
Uno dei personaggi più riusciti del romanzo è la mamma di Arkadij, Sofia Andréevna, donna di umili origini, sposa di Makar Ivanov Dolgorouki, giardiniere di Versilov. Dostoevskij ce la presenta con questa intrigante premessa: «certe donne seducono con la loro bellezza o con altri loro modi in un attimo; altre, invece bisogna avvicinarle almeno per sei mesi prima di capire cosa realmente siano, e per innamorasi di loro […] occorre, anzitutto, esser dotati di un certo acume». Con rara sensibilità Dostoevskij riesce poi ad entrare nell’animo di questa tenera donna, nella sua semplicità dotata di grandissima amorevolezza e sensibilità; l’unico personaggio che rimane saldo nel vortice degli eventi.
«L’idea» di Arkadij è quella di puntare tutto su «tenacia e continuità» per diventare un giorno ricco come Rothschild. Dostoevskij ne approfitta per darci una bella lezione sulla forza di volontà: «C’è al mondo una gran differenza di forze, specialmente di forza di volontà. Esiste la temperatura dell’acqua a bollore e quella del ferro incandescente». Arkadij avendo messo alla prova la sua volontà sa di poter raggiungere la sua meta, anzi qualunque meta. In queste righe non possiamo non scorgere, in controluce, il “segreto” di Dostoevskij stesso che, resistendo a quattro anni di lavori forzati in Siberia, riuscì, con una determinazione suprema, a diventare uno dei più grandi scrittori della letteratura occidentale. In un altro passo Arkadij ci sorprende con una osservazione ancora più illuminante: «la coscienza solitaria e sicura [corsivo dell’autore] della mia forza! Ecco la definizione della libertà che il mondo cerca con tanta ansia». Ai giorni nostri un cantante che viene tuttora considerato un “genio” in una canzone cantava che «la libertà è partecipazione»; vedete che antitesi con «la libertà è la coscienza solitaria e sicura della mia forza»; spero notiate che differenza di spessore! c’è “genio” e genio… (Se fossi stato un giornalista avrei intitolato questo post “Dostoevskij contro Gaber”!).
E quanto alla meschinità del sogno di “diventare ricco come Rothshild” Arkadij risponde facendo eco al principe Myŝkin: «Beato colui che ha l’ideale della bellezza seppur errato!» È questo un concetto tipico di Dostoevskij, e che torna spesso lungo tutto il romanzo.
Quanto alla classe dirigente, Versilov ‒ che è un po’ il Dr Jekyll e Mr Hide della situazione ‒ in una delle sue impennate più alte dice, a proposito dell’aristocrazia: «L’idea dell’onore e della cultura come obbligo per chiunque voglia entrar a far parte d’una classe non chiusa e che senza tregua si rinnova è certamente un’utopia, ma perché non dovrebbe essere attuabile? Se questa idea vive sia pure soltanto in pochi cervelli, non è ancora perita e illumina, come un barlume di luce in una tenebra fitta». E di fronte al più prosaico principe Sergei, Versilov ribatte con un affondo: «Perché vivere secondo un’idea è difficile, mentre è facilissimo invece vivere senza idee».
Notevolissima è anche la “favola” della conversione di Maksim Ivanovic, una breve parentesi all’interno del romanzo, che costituisce un racconto a sé di grande impatto emotivo. Questa è una di quelle “resurrezioni morali” che più di una volta si incontrano in Dostoevskij e che penso abbiano pure ispirato l’ultimo grande romanzo di Tolstoj, Resurrezione.
Di grande fascino è il personaggio dell’ex giardiniere, poi pellegrino, Makar Ivanovic, una sorta di monaco errante senza essere monaco, una specie di santo incapace di provare odio o rancore per chicchessia, ingenuo e saggio allo stesso tempo, col sorriso gioioso di un bambino. Qui riceviamo anche un’altra lezione sul riso: «nel riso è la più sicura rivelazione dell’anima» conclude Dostoevskij dopo una lunga e profonda analisi.
Detto ciò, mi sembra di non avere ancora neanche incominciato a parlare di questo libro-miniera. Considerate questo: è come se, volendo mostrarvi una spiaggia grandissima, vi avessi portato solo qualche granello di sabbia.